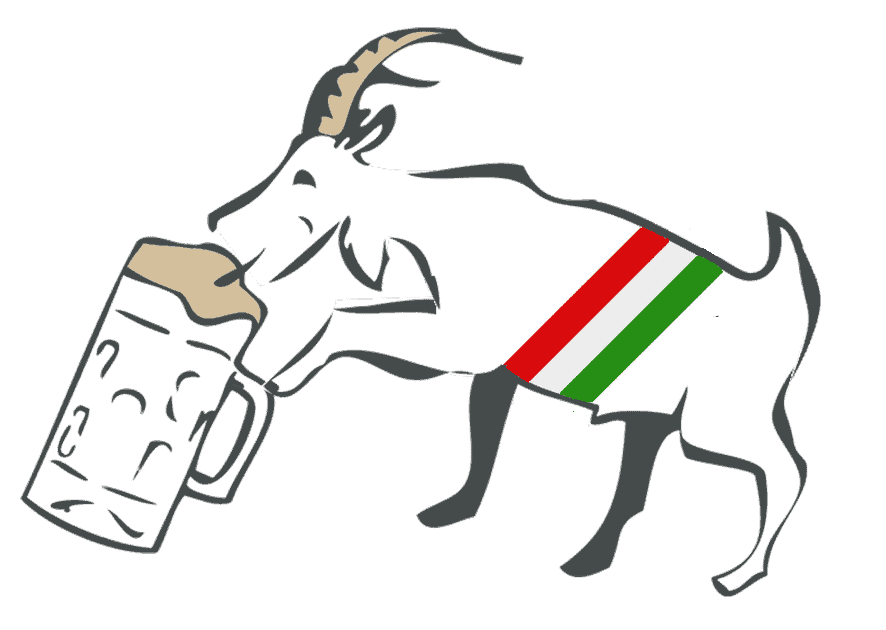Evoluzioni stilistiche: vedremo l’alba delle Italian Bock?
Il senso degli italiani per le Bock. Da questa immagine di sintesi (ispirata, com’è chiaro, al romanzo Il senso di Smilla per la neve, dello scrittore danese Peter Høeg) possiamo utilmente partire nella trattazione del tema attorno al quale ruota lo spunto di riflessione che proponiamo oggi. Tema il cui contenuto, a sua volta, prende le mosse da due domande.
La prima: esiste un’accezione più o meno condivisa attraverso la quale i birrai del nostro Paese tendono a declinare il modello stilistico delle Bock tedesche? E, in caso di risposta affermativa, si ravvisano già adesso – questa la seconda domanda – le precondizioni in virtù delle quali sia possibile ipotizzare il configurarsi di un nuovo sottostile originale, chiamato a prendere l’eventuale denominazione di Italian Bock?
Ebbene, diciamo subito che, per quanto riguarda il secondo punto (suggestivo, a nostro parere), la sua soluzione è destinata a rimanere un argomento in sospeso, anche soltanto per il fatto che la prospettiva evocata si trova attualmente in uno stato di semplice idea. Tornando invece all’interrogativo iniziale, ci sembra che, a tale proposito, gli elementi sul terreno siano decisamente meglio definiti e tali da consentire di rispondere che, sì, i produttori itaiani, nel cimentarsi con la tipologia originaria di Einbeck (comprendendo, nel presente ragionamento, anche la sua discendente diretta monacense: ovvero la Doppelbock), manifestano un’inclinazione di massima a fornirne interpretazioni abbastanza convergenti.
Una constatazione, questa, che si è palesata in modo spontaneo, prendendo atto di come, con sostanziale regolarità, nello scambiare impressioni attorno alle Bock firmate dai marchi artigianali nostrani, si evidenziassero caratteristiche tali da costituire una sorta di paradigma: un paradigma non ricercato in quanto esecuzione di un modello codificato al quale aderire consapevolmente, ma piuttosto affiorante come risultato di un comune sentire che, senza essere emerso a livello esplicito, ha tuttavia portato numerosi birrifici nostrani a personalizzare l’archetipo Bock secondo forme ormai facilmente identificabili.
Ma quali forme? Anzitutto una certa propensione a orientarsi verso il limite inferiore (se non proprio superarlo) della finestra relativa ai valori alcolici di riferimento per la categoria (a fini d’inquadramento, riportiamo le indicazioni riferite dal BJCP: da 6.3 a 7.4 gradi per le Helles Bock; da 6.3 a 7.2 per le Dunkles Bock; da 7 a 10 per le Doppelbock). In seconda battuta, una lampante risolutezza nel plasmare la corporatura della bevuta secondo principi di agilità e scorrevolezza: evitando quegli accumuli zuccherini (tra malti speciali e frazioni fermentabili non svolte) che arrotondano così pinguemente i fianchi delle canoniche Bock germaniche. Terzo punto (in parte legato al precedente), la ricerca di un naso meno pendente verso il lato caramellato della forza; quarto comma, infine, la modellazione di un bilanciamento gustativo-palatale nel quale le componenti di amaricatura apportate dal luppolo sono arruolate in misura non diremo massiccia, ma senz’altro superiore rispetto all’ortodossia tedesca. Insomma, tutto un insieme di prerogative confluenti verso l’obiettivo di rendere la sorsata quanto più possibile agevole e reiterabile.
A veder bene si è di fronte a un parabole dotata di una sua coerenza; certo, una parabola non perfettamente lineare (proprio perché non condotta con volontà lucida e consapevole, nei termini di percorso intenzionale), ma scandita da accelerazioni impresse spingendo ora su un pedale ora su un altro, tra quelli che abbiamo evidenziato come parametri distintivi delle Bock tricolori; eppure, al netto di tutto ciò, una parabola che ha iniziato a tracciarsi fin da alcune tra le prime esperienze nazionali entro il perimetro Bock e Doppelbock.
Il riferimento è, ad esempio, alla Bibock del Birrificio Italiano (6 gradi) e alla Porpora di Lambrate (8 gradi), con le loro incisive venature amaricanti. A partire da tali premesse, si è prodotta una genealogia nella quale – solo a titolo di campionatura, tra le tante altre etichette rappresentative da poter citare a sostegno della tesi qui sostenuta – ricordiamo birre quali La Heller Bock di Elvo (7 gradi, tessitura snella e, di nuovo, dotata di lineamenti luppolati); la Falesia di Lariano (7 gradi, asciutta e pericolosamente scorrevole); la Deiva di Altavia (6 gradi e 8, essa stessa dal sorso assai disinvolto); La Bock di Ritual Lab (6.2 gradi) e la Bock di Birracruda (6.7 gradi), dotate entrambe di una chiusura, a loro volta, asciutta ed equilibrata. Vale la pena menzionare infine Il Montante di Brewist (Doppelbock da 7 gradi e 3), un bicchiere che, nelle proprie evocazioni pugilistiche, risulta emblematico nel tratteggiare il temperamento suo e delle sue sorelle italiane, abili a dissimulare la rispettiva forza alcolica e, perciò, capaci di colpire e stendere con facilità micidiale.